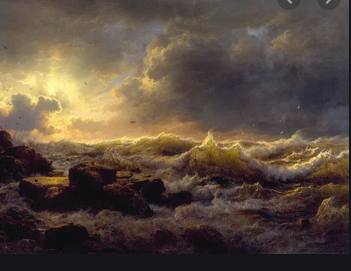
BY: Renato Barbruni
- Il silenzio come “rinuncia” alla presenza
- Il silenzio come “attesa” di una presenza
C’è un silenzio che è rinuncia alla presenza, che è mortificazione, o meglio automortificazione. Questo silenzio è presente nelle situazioni di sofferenza esistenziale. La persona che vive il dolore derivante dalla propria esistenza, che è vissuta come vuota, inutile, priva di scopo e senso, si condannano al mutismo, al silenzio in quanto rinuncia a produrre la propria parola sul mondo e nel mondo. E’ ammutolito in quanto la parola, il dire di sé a sé o ad altri, non ha più alcuno scopo, essendo egli svuotato di intenzioni relazionali. Il motivo per cui pronunciamo parole sta nella relazione, scaturisce dall’istituzione di una relazione. La parola è il terzo che unisce i due. Ma prima della parola, c’è l’intenzione di coprire la distanza tra i due che sono lì convenuti; prima ancora dell’intenzione di coprire tale distanza, è necessario che essa sia percepita e sia causa di struggimento e di nostalgia per la ricomposizione della unità umana primordiale. Ciascuno di noi porta dentro di sé la ferita primitiva della scissione dell’essere. E’ quella ferita che ci racconta di una antecedente unitarietà relazionale tra il soggetto presente a se stesso e il soggetto allontanato da sé. Per fare un esempio semplice, che illustri questo stato dell’anima, basti pensare alla unità primordiale tra il bambino nel ventre della madre e la madre stessa. Ogni essere umano sorge alla propria esistenza entro l’orizzonte di un rapporto, egli è parte di quel rapporto. Possiamo anche pensare, in termini più assoluti, che il soggetto è parte di una relazione cosmica: da essa egli sorge alla propria singolarità, che conquisterà nel momento in cui vedrà scindersi la relazione primordiale e primitiva. L’esperienza interiore della scissione, che conduce alla singolarità, permane negli strati più profondi dell’anima a memoria dell’unità antecedente. Da questa ferita permanente, memoria di un’epoca e di un evento che ha costituito il soggetto nella sua unità di singolarità, scaturisce tutto l’intenzionarsi racchiuso nella parola, in tutte le svariate forme attraverso le quali si esprime. La parola è il suono emesso dalla bocca dell’uomo, ma essa abbraccia anche tutti i segni che egli sa produrre e che possiedono la qualità di promuovere la comunicazione. Per comunicazione non si intende tanto il trasferimento di un dato di conoscenza da un punto all’altro, ma proprio il rendere comune quel dato di conoscenza, far sì che i due, riconoscendosi in esso, ritrovino l’atmosfera della loro relazione. “..Fai che loro siano in me come io sono in te, da essere una cosa sola…[1]”, si legge nel Vangelo di Giovanni a significare la ricomposizione salvifica dalla scissione causata dal peccato originale, il quale si configura come la separazione-scissione per antitesi tra l’uomo e Dio Padre, tra il singolo e l’universale. Il singolo costituitosi come tale immediatamente si pone in antitesi con l’universale da cui è sorto. L’atto costitutivo del singolo è un atto di superbia, intesa come atto di antitesi. In questo senso l’intellettuale, il singolo che si crede intelligente, si pone sempre in antitesi all’esistenza di Dio. Come quell’uomo che non vuole innamorarsi per non perdere la propria individualità[2], anche se continua a cercare una donna, in quanto la mancanza di un affetto gli pesa. Quindi egli cerca l’esperienza della comunione quasi sempre confusa con la ricerca del piacere sessuale. In verità si può vivere un’esperienza di unione senza perdere la propria individualità. L’arte rinascimentale mette in scena l’armonia e la comunione, mentre l’arte del novecento raffigura, nelle sue opere, la scissione (vedi Picasso e le opere dell’astrattismo). Queste immagini sono penetrate nella coscienza di ciascuno inquinando la capacità di intuire la comunione. L’archetipo che emerge dalla teologia cristiana della Trinità raffigura la comunione nella distinzione, concetto che la logica aristotelica e la logica novecentesca non sanno capire. La capacità di saper cogliere l’elemento trascendente tra i due che si avvicinano, è estremamente importante, perché costituisce l’elemento decisivo per l’acquisizione dell’esperienza della comunione tra un soggetto e l’altro.
Quell’esperienza diviene il terzo che unisce, o meglio, ri-unisce i due, ricomponendoli nella antecedente unità primordiale. Quando l’esigenza di questa unità primordiale non è più percepita o, a causa della sofferenze non tollerata, viene rimossa e annichilita, il soggetto si sottrae al sentimento di comunione e la parola diviene oggetto inutile. Da qui il mutismo e il silenzio conseguente.

C’è un silenzio che è “attesa” di una presenza, di presenza a se stessi, quando le parole narrano della vera essenza e di ciò che necessita alla vita interiore.
Lì si levò un albero. Oh puro sovrastare!
Orfeo canta! Grandezza dell’albero in ascolto!
E tutto tacque. Ma proprio in quel tacere
Avvenne un nuovo inizio, cenno e mutamento.
Animali si silenzio irruppero dal chiaro
Bosco liberato, da tane e nascondigli
E si capì ch’essi non per astuzia
O per terrore in sé eran così sommessi,
ma per l’ascolto. Ruglio, grido, bramito
parve piccolo nel loro cuore. E dove quasi
non v’era che una capanna al suo ricetto,
un anfratto delle più scure brame ordito,
con un adito dagli stipiti sconnessi, –
tu creasti per loro un tempio nell’udito.
La stupenda poesia di Rilke descrive il miracolo della nascita di un nuovo soggetto d’ascolto, come un universo che si dispiega in forma radiante. Ma il nuovo soggetto dell’ascolto è tutt’uno con il nuovo soggetto narrante. Ed è un ascoltare che si fa percezione delle profonde trame dell’essere (“…un anfratto delle più scure brame ordito,…”) che, mute, silenti e lontanissime dall’orecchio dell’Io, debordano in echi che scavalcano la barriera dei concetti-costrutti della mente, per vivificare (“…tu creasti per loro un tempio nell’udito.”) la sostanza essenziale dell’anima. Un ascolto quindi che dilata la dimensione percepita ed intuita dell’essere. Questo evento risveglia un particolare stato d’animo in cui si riflette una disposizione dell’anima, che generalmente rimane chiusa e soffocata dal limite delle percezioni sensoriali. L’ascolto del mondo, in quel caso, è limitato agli eventi fisici colti sul piano della pura materia; ma, quando varchiamo l’asse della sensorialità e ci inoltriamo verso la dimensione dei significati, l’ascolto si fa più sottile, ma al tempo stesso, meno credibile perché preso dai dubbi circa il vero significato da attribuire all’evento. Nella poesia di Rilke è descritto l’ingresso improvviso della dimensione dello spirito nell’ascolto dell’essere, che, colto nella sua natura essenziale di puro spirito, restituisce la primaria esperienza della certezza.
C’è quindi
un silenzio dello spirito, quanto la fonte stessa dell’esistere declina
verso dimensioni che appaiono vuote,
come il nulla. “Dio mio perché mi hai
abbandonato?[3]”.
E’ qui raffigurato l’assolutamente solo, l’assolutamente staccato dal flusso
del senso. Gesù non muore in pace, non affronta la morte e il dolore che la
precede, con serenità ma, se pur con forza, coraggio e accettazione, affronta
l’evento con angoscia. Perché? Proprio
Gesù così ripieno di Spirito Santo, così vicino a Dio da essere a lui
consustanziale, da esserne il figlio prediletto e la forza incarnata; Gesù che
ha compiuto i miracoli, come può affrontare la morte e la sua sofferenza con
angoscia? Dovrà vivere da uomo, e da uomo affrontare il grande tema dell’esistenza
umana: il sentimento della solitudine che è il retaggio della
scissione tra l’uomo e Dio. Già nell’orto degli ulivi Gesù incomincia a rimuove
da sé Dio. Già percorre il cammino verso la piena incarnazione per vivere da
uomo, e affrontare il dolore da uomo, non da Dio. E’ la solitudine che marca il
confine stabilito e tracciato tra l’umano e il divino. Ma è una solitudine
apparente, percepito dal gioco errato della percezione e della logica del
pensiero. Nell’atto “Nelle Tua braccia rimetto il mio spirito”, Gesù ritrova
nell’intuizione dell’amore da cui si
sente avvolto, la Presenza di Dio Padre. Ecco che il silenzio dalla parole e
dai concetti, fino a quel momento usati,
permette il riemergere della Presenza che si è tenuta lontana. Ed è
nell’amore che il soggetto amante ritrova il senso della Presenza del Soggetto
amato, in ciò si attua la comunione tra i due. “Nessuno ha mai visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in
noi e l’amore di lui è perfetto in noi.”[4] L’amore convoca
Dio, la Presenza del Senso riconduce all’unità primordiale superando così l’esperienza
della scissione.
[1] Giovanni 17,21
[2] L’uomo egocentrico, tipico della società individualistica contemporanea, perde la capacità di cogliere la trascendenza, di vedere cioè ciò che lo unisce all’altra persona, Egli è dominato dal piacere e dalla visione dionisiaca attraverso la quale la sessualità è percepita come atto di dominio e uso dell’altro, non certo di comunione.
[3] Marco 15,34; Salmi 22 (21), 2
[4] Prima lettera di Giovanni 4,12
